Da qualche tempo è ormai pronto il numero zero di una rivista che, con alcuni amici, abbiamo chiamato “Crinali”. L’imperizia, il poco tempo, le scarse risorse e alcuni inconvenienti ci impediscono di darle una veste definitiva. Il numero che qui anticipo e propongo è interamente dedicato al quartiere “ghetto” del CEP di Genova, una pustola di cemento tra le delegazioni di Prà e di Voltri.
Il tema sotteso, di cui mi sono reso conto lavorando ai testi e ai disegni che costellano la rivista, è quello dell’appartenenza e dell’identità.
Contributi di Gianni Priano, Piero Aquilino, Gianpaolo Rappa, Cosimo Damiano Motta, Alberto Folli
UN RICORDO MILITANTE
di Piero Aquilino (Sindacalista)

Pur avendovi partecipato, non ho ricordi molto nitidi dell’occupazione delle case CEP nei primi anni ’70. Forse perché la memoria individuale (almeno la mia), come quella collettiva, tende a rimuovere le anomalie e l’occupazione del CEP fu, nel panorama genovese, molto legato alle vicende di fabbrica, una lotta anomala: erano diversi i soggetti – immigrati meridionali invece che operai genovesi – ed era diverso l’ambiente – un nuovo quartiere sulle colline invece che una fabbrica tradizionale.
A memoria non saprei dire la data esatta, ma ho ben presente la situazione politica nella quale avvenne: le lotte operaie degli anni precedenti avevano ottenuto importanti conquiste salariali e normative, ma stavano segnando il passo e non riuscivano a coprire bisogni sociali fondamentali, primo tra i quali la casa, anche in una città come Genova, che non aveva conosciuto un’immigrazione di massa paragonabile a quelle di Milano e Torino. L’esigenza di vivere in un’abitazione decente, oltre che condizioni di lavoro umane e un salario non da fame, si scontrava con la gestione clientelare delle case popolari, che pure in qualche misura erano state realizzate, e nel disinteresse dei partiti “storici” della sinistra e dei sindacati. Ricordo che uno dei requisiti per farsi assegnare un appartamento era di abitare in “grotte o spelonche”: con queste premesse era chiaro che chi voleva una casa decente prima di morire doveva darsi una mossa…
In questa situazione, l’alluvione del 1970 era stata tutt’altro che una goccia e aveva fatto traboccare il vaso, rendendo inagibili molti appartamenti del centro storico di Voltri abitati per lo più da immigrati (allora calabresi o siciliani e non senegalesi o ecuadoriani).
Se non ricordo male, i primi tentativi d’occupazione partirono proprio da lì, indirizzandosi verso i condom ini vuoti e in attesa di assegnazione. Il CEP era stato costruito dai primi anni ’60 come quartiere dormitorio assolutamente privo di servizi. Le case già assegnate erano abitate quasi esclusivamente da meridionali guardati con sospetto dagli indigeni che, per definire i più giovani, avevano coniato l’indicativo neologismo di “ceppisti” (CEP + teppisti). Le costruzioni più in alto erano invece vuote da anni, in attesa di assegnazione e prive di acqua ed elettricità. Proprio per il carattere di ghetto del quartiere, non mi sembra che avvenissero episodi frequenti invece in zone più ambite, come ad esempio Coronata. Lì molti appartamenti popolari, tramite un’oculata gestione delle liste, erano assegnati a dipendenti statali o a “amici degli amici” che non ne avevano una reale necessità. Questi, dopo avervi introdotto qualche mobile per sancire la presa di possesso (e per trasformare un’eventuale occupazione in furto con scasso), lo subaffittavano a qualche famiglia di disperati guadagnandoci sopra.
ini vuoti e in attesa di assegnazione. Il CEP era stato costruito dai primi anni ’60 come quartiere dormitorio assolutamente privo di servizi. Le case già assegnate erano abitate quasi esclusivamente da meridionali guardati con sospetto dagli indigeni che, per definire i più giovani, avevano coniato l’indicativo neologismo di “ceppisti” (CEP + teppisti). Le costruzioni più in alto erano invece vuote da anni, in attesa di assegnazione e prive di acqua ed elettricità. Proprio per il carattere di ghetto del quartiere, non mi sembra che avvenissero episodi frequenti invece in zone più ambite, come ad esempio Coronata. Lì molti appartamenti popolari, tramite un’oculata gestione delle liste, erano assegnati a dipendenti statali o a “amici degli amici” che non ne avevano una reale necessità. Questi, dopo avervi introdotto qualche mobile per sancire la presa di possesso (e per trasformare un’eventuale occupazione in furto con scasso), lo subaffittavano a qualche famiglia di disperati guadagnandoci sopra.
Nel disinteresse del PCI, che pure all’epoca era all’apice della sua espansione e che raggiungeva nella zona percentuali elettorali da Unione Sovietica, l’intervento politico e l’organizzazione delle occupazioni fu gestita dalle principali organizzazioni dell’estrema sinistra genovese: Lotta Continua e Lotta Comunista. È difficile immaginare due organizzazioni più diverse da un punto di vista politico e organizzativo e il ritrovarsi su un comune terreno d’intervento portò a una tensione crescente che sfociò anche in alcuni scontri fisici, causando l’abbandono del campo da parte di Lotta Continua.
All’epoca militavo in Lotta Comunista e ricordo che gestire l’occupazione di alcune centinaia di famiglie ci costrinse ad affrontare grossissimi problemi pratici. Come ho già scritto gli appartamenti occupati non avevano acqua ed elettricità. Il primo problema fu risolto con un allacciamento provvisorio alla sorgente di un contadino confinante. Il secondo, noleggiando due grandi gruppi elettrogeni diesel sistemati nei fondi aperti di un fabbricato. Data la stagione invernale, farli funzionare e sorvegliarli fu penosissimo perché ci costringeva a turni di guardia di dodici ore al freddo.
Essendo addetto all’organizzazione (essenzialmente alla sorveglianza dei gruppi elettrogeni, oltre che alla stampa di volantini), non ho particolari ricordi delle assemblee periodiche con gli occupanti, alle quali partecipavano i compagni impegnati nell’intervento politico. Dai loro racconti emergeva una composizione degli occupanti molto eterogenea fatta di proletari e di sottoproletari, tutti accomunati dal fatto di essere immigrati dal Sud e senza casa: gli operai si mescolavano a personaggi dai mestieri improbabili, tra i quali ricordo un “giocatore di biliardo professionista” che all’epoca mi aveva meravigliato. Un particolare curioso: nelle discussioni tutti si rivolgevano agli altri con il “tu” salvo a un personaggio cui era rivolto un più rispettoso “vossia”: ovviamente la voce comune era che fosse un “amico degli amici”.
Le forze dell’ordine non intervennero mai direttamente. Si limitavano a sorvegliare le vie d’accesso, fermando e perquisendo le nostre auto. Su una di queste, una pattuglia di Carabinieri sequestrò alcuni manifesti scritti a mano (allora si chiamavano “tazebao”, alla cinese) nei quali solidarizzavamo con gli occupanti e offrivamo la nostra collaborazione e il nostro appoggio. Un solerte magistrato (mi sembra di ricordare che fosse il dott. Sossi) rinviò a giudizio gli occupanti della vettura per: stampa clandestina (anche se erano fogli scritti a mano), associazione per delinquere (perché gli attacchini erano più di uno), apologia di reato e istigazione a delinquere (perché inneggiavano all’occupazione) e, infine, tentato delitto (perché non li avevano ancora affissi). Il processo, che si celebrò nel PalazzoDucale, fu una farsa e finì con un’assoluzione generale. Tra l’altro, i militi avevano dimenticato di sequestrare secchio e pennello, facendo così mancare la prova decisiva del “tentato delitto”. Il clima però era quello e l’era dei “giudici comunisti” era ancora lontana a venire…
Col tempo si esaurì la fase militante dell’occupazione. Lotta Comunista costituì una sorta di sindacato degli occupanti, l’Associazione degli Inquilini Proletari, esistente tuttora, che gestì i rapporti con Enel, Amga e le trattative con le istituzioni per la stabilizzazione delle occupazioni. Non mi risulta che ci siano stati sgomberi negli anni successivi e, nella mia attività sindacale al Cantiere di Sestri, mi è capitato d’incontrare figli o nipoti degli occupanti di allora ancora residenti al CEP.
Quello del CEP di Pra non fu l’unico episodio. Si occuparono case anche a Coronata, Giro del Vento e, forse, a Quezzi.
Tutto sommato furono lotte positive perché raggiunsero il loro obiettivo: dare una casa a chi non l’aveva, oppure abitava in condizioni disastrose e soprattutto perché dimostrarono l’esistenza, in condizioni difficili, di una vitalità popolare che oggi – purtroppo – manca.
DALLA ROSA E L’ERBA LUISA AL CELLOFAN SUI GABINETTI – VOLI MIGRANTI SUL FILO DELL’IDENTITA
di Alberto Folli (counselor)

Dopo tanti anni di frequentazione in cui ho ascoltato e riascoltato queste ed altre storie, complice un invito a pranzo in vista del cinquantesimo dell’arrivo a Genova, ho deciso di intervistare mia suocera. L’intervista è diversa dalla chiacchierata perché la ascolterò con una attenzione mirata e con una particolare intenzionalità. Ho uno scopo esplicito e un tema, che le comunico subito: “Signora vorrei che mi parlasse della sua vita nel quartiere del Cep, dove abita. Mi interessa l’aspetto dell’appartenenza e dell’identità in rapporto al quartiere”.
Mia suocera ha 86 anni, è arrivata a Genova nel 1964 all’età di 36 e con all’attivo già 6 figli. Qui nascerà l’ultima, mia moglie.
Possiede quel genere di cultura profonda e temprata dalla vita, che deriva da una famiglia solida, contadina e solidale: suo padre, classe 1886, era un saggio agricoltore, simpatizzante socialista. La voce calca su questa parola: “Massaro; lo sai cosa vuol dire massaro!? Aveva quattro muli, coltivava la terra, tante cose che era difficile avere in paese. Ha sposato cinque figlie con la dote”. Sposò sua madre quando questa aveva 16 anni e lui 11 di più. La ragazzina era intelligente e colta: leggeva e scriveva e tutti, dal microcosmo buterese fino a Gela, ne riconoscevano la “rispettosità” verso la famiglia e da tutti era rispettata, in primis dal marito.
Il rispetto e l’espressione d’affetto pubblici verso la propria moglie sono una merce preziosa, ancora oggi. Per questo ci siamo stupiti, durante una recente gita al Cep fatta con gli amici, di leggere scritte sui muri inneggianti l’amore coniugale. Nel genere writer una rarità, e proprio nel luogo in cui per due volte ritrovai la moto che mi era stata rubata; ma torniamo a tavola.
Mia suocera ha preso a parlare del primo approdo a Genova della sua famiglia, della prima casa in Via Sivori, della piccola omissione del marito che, parlando con la portinaia e con i proprietari, aveva ridotto a due il numero dei figli, rinunciando a dichiarare gli altri quattro. Troppi per una famiglia meridionale che cerca alloggio. In una smorfia di labbra ricorda i cartelli sui portoni: “Non si affitta ai meridionali”. Non mi stupisce: vent’anni anni dopo, cercando alloggio per i miei genitori mi sono sentito chiedere: “Avete meridionali in casa?”.
Non accendo ancora il registratore perché non è di quel periodo che voglio sentire. Intanto lei parla, parla per un’ora delle due case cambiate in pochi mesi e in pochi metri di distanza: Via Sivori, appunto.
Un intervento di sua figlia porta il discorso al dunque. Al mio dunque, e dunque accendo il registratore e parto con la prima domanda. “Quello del Cep vuoi sapere? Allora, abitavamo in Salita San Barnaba, parto da lì da come siamo arrivati in S. Barnaba”.
Come sottrarsi? La speranza che si tratti di una breve parentesi si infrange sulle portate del pranzo domenicale: passa l’antipasto, la pasta e la pizza, la melanzana alla parmigiana, ed è solo dopo l’anguria che ci avviamo a parlare del Centro edilizia popolare.
“…e siamo venuti ad abitare al Cep”.
Basta. Dopo la precedente valanga di dettagli, sul Cep solo questo. Poche parole, un sospiro e uno sguardo che sanno di sconfitta. Lapidaria. Ha finito e tace. Il suo silenzio incontra il mio che è immobile e interlocutorio. Io capisco che c’è più in quel silenzio che in tutto quello che potrà raccontare e lei capisce che deve dire di più. Infine inizia, tra le sirene delle ambulanze che passano in strada ululando, metafora dell’urlo e del pianto, del grido che vuole coprire ogni parola.
Prima di procedere al resoconto sul quartiere che mi interessa, un particolare sulla casa di San Barnaba debbo pur consegnarlo alla memoria scritta. La grande casa con giardino, dal sapore di villa nobiliare di campagna in pieno centro, consegnata dal proprietario che si presentò in bombetta e li accolse con una grazia antica, è il luogo del mito familiare genovese; quello a cui tutti, genitori, fratelli e sorelle, sono legati come lo si è al proprio cordone ombelicale.
E’ il luogo del mito e dei valori, delle buone cose, delle fatiche, delle incertezze e anche delle speranze; dei figli che giocano e degli animali domestici, del calore che fatica a riempire le stanze dagli alti soffitti affrescati; del sole e dell’ombra nel giardino, quando d’estate il tempo dei bambini si dilata e sembra tendersi tra la polvere e una fragola colta di nascosto dal piccolo orto.
E tutto questo vede allora mia suocera, la guerriera visionaria, quando sceglie quella casa, chiusa da tanto tempo, segnata dalle lunghe falde delle ragnatele. Vede una rosa intrecciata ad una pianta di erba Luisa, la invade il loro profumo, è maggio, e capisce che lì cresceranno i suoi figli.
Dopo qualche tempo però l’intero stabile, che è in vendita, trova acquirenti. Il proprietario è dispiaciuto e si esprime così: “Pensavo che la bottiglia di Champagne uscisse dall’alto e invece mi scoppia sui piedi”, ma è un gentiluomo e fa in modo che la famiglia possa restare finché non trova una nuova sistemazione. “Mi sono messa d’accordo con i proprietari e ho fatto domanda alle case popolari e me l’hanno data qui”. Era l’ottobre del 1976.
“E siamo venuti ad abitare al Cep”. Riascolto la frase al registratore, ne risento la vena, la frattura.
I conti con i sé e con i ma, sono così fatti: tante le cose inadeguate che vedeva: gran lavoratori con i figli che vendevano droga; disagio, dolore, suicidi, famiglie operaie e malattia mentale, spaccio, incuria, degrado. “Da 41.000 lire ero passata a 25.000 in S. Barnaba e poi a 59.300 in Via Cravasco, tanti. Dovevo dire non mi prendo la casa popolare e con la stessa cifra mi pago un affitto in centro, in Via Sivori”.
Invece prevale il senso della sicurezza: “Non mi manderà più nessuno. Cioè, non dovrò più portare le referenze, la casa è mia anche se in affitto, poi magari la compro. E così è stato nel ’93, quando ormai pagavo 700.000 lire di canone”. E’ sempre precisa sulle date mia suocera, il suo calendario è costellato dalle nascite e dai matrimoni di figli e nipoti.
Scegliere la sicurezza al Cep; sembra un paradosso, una scelta folle, ma io credo che solo chi è stato sfrattato, chi ha consumato la notte sugli annunci dei giornali, può misurare per intero lo spessore di questa frase: “non mi manderà più nessuno”. Intuisco anche il peso, forse l’umiliazione, il dolore in quel dover “portare le referenze”.
A questo punto avrei dovuto capire tutto perché gli elementi erano lì in quelle parole già pronunciate. Invece mi è stato necessario ancora un po’ di tempo, ancora un po’ di narrazione.
Ho incalzato il discorso cercando di portarlo sul tema dell’appartenenza, sul rapporto tra quartiere e identità o sul suo contrario.
“Non sono venuta qui con tanto affetto” dice “A malincuore. Il mio impatto con la città è stato Via Sivori; là se ancora ci vado mi conoscono diversamente”.
Ah, se a questo punto non avessi temuto che ricominciasse a parlare di Via Sivori, avrei forse capito l’importanza di questa frase: “mi conoscono diversamente”, una frase che risulterà veramente chiara solo alla fine, tornando in Sicilia.
“Qui invece tutti ci guardavamo…” con sospetto vorrebbe dire, ma è reticente a esprimersi su quel mondo di cui fa parte, con cui aveva qualcosa in comune e che molto le era distante: in quel coacervo di famiglie operaie, di analfabeti, di tossici, di persone che vivevano di espedienti (dal contrabbando di sigarette allo spaccio di droga, all’assistenza sociale). Vivere lì: un affronto che non avrebbe voluto tollerare. Un quartiere che non era comunità, in cui era difficile andare oltre il rispetto della buona educazione perché prevaleva la diffidenza, se non la paura per i propri figli. Un ambiente in cui non trovava un appoggio.
I sacerdoti erano già arrivati, Padre Balbi, Don Sergio, nella chiesa nei fondi del palazzo (prima di spostarsi dove è attualmente, all’altro capo della Via), tentava forse di costruire, attorno alla croce, quel minimo denominatore comune che permette alle persone di riconoscersi. Forse grazie a loro nascono nel quartiere anche la Croce Azzurra e il Gruppo Sportivo. Don Sergio andava nelle case a cercare i ragazzini per coinvolgerli, per non perderli. Poi, più di recente, anche i preti sono cambiati rapidamente, anche loro provenendo da paesi lontani, più lontani, e davanti alla chiesa (quasi una chiesa da campo) c’è una statua in marmo, con le braccia basse e i palmi aperti: la madonna dell’accoglienza.
Il quartiere stava formandosi e le persone provenivano da paesi diversi, la Sicilia, la Calabria, la Sardegna. L’essere tutti meridionali non sembra un collante culturale abbastanza forte e anche se tante sono le famiglie oneste non c’è condivisione di una scelta, solo ci si può sentire tutti come foglie secche, come spazzatura che il vento ha ammucchiato qui, in quest’angolo piuttosto che in un altro, a casaccio. In questo posto dove nessuno è nato e nessuno è ancora nato; un posto senza passato, sorto ai margini delle storie altrui: Voltri, Prà. Luoghi e persone che non riconoscono ancora quel quartiere come un pezzo della loro stessa storia.
Ecco, ora capisco meglio il senso di spaesamento. Non sono tanto i problemi sociali, che pure ci sono, quanto l’impossibilità di vivere in una vera comunità, fare amicizie profonde, potersi permettere di avere qualcosa in comune: una storia, un progetto di continuità legato al luogo in cui si vive. Ancora una volta però qualcosa mi sfugge, mancano dei significati ai concetti che uso nelle mie domande: appartenenza, identità, ma tutto sarà chiaro al termine del racconto.

“Il quartiere è cresciuto, qui di fronte non c’era niente, solo il grattacielo“. Aprirà un bar che subito diventerà luogo di spaccio e quindi verrà chiuso e poi riaperto.
Stanno finendo gli anni ’70. C’è tensione nell’aria; ci sono scontri forti in tutta la città, scontri politici ma anche sociali. I figli degli immigrati non accettano la situazione di marginalità in cui si trovano, rispondono con una violenza evidente ad una violenza più sottile che avvertono sulla pelle.
Negli anni ’70 la droga si presenta e gli anni ’80 daranno la stura all’eroina. Si discute e ci si chiude, comitati e bottigliate, liti, paura, angoscia. Qui come altrove, ma qui, sicuramente, graffiando a fondo l’asfalto e gli intonaci di queste case popolari, che sembrano realizzati con materiali di scarto. Nonostante qualche tentativo di animazione con la musica, che nel breve periodo allontana gli spacciatori, la radice maligna rimane, affonda nel disagio di molti. “Sai quanti ragazzi sono morti qui? Tanti; qualcuno lo conosci anche tu, nel palazzo di là tutti i figli sono morti per droga. Non è così per tutti qualcuno è diventato un lavoratore.”
I figli si ribellano ai genitori, è un obbligo generazionale sopratutto in quegli anni. Anche i figli di mia suocera cercano vie di fuga. In gran parte rifiutano il quartiere, tornano in centro appena possono. Chi non può è tenuto stretto, in casa.
Sì, la casa. Il luogo a cui si torna dopo una giornata di lavoro o di scuola in centro. La casa nuova che permette il pensiero di poterla comprare. “Quando sono andata via da Salita San Barnaba non ero in grado di comperare la casa; avevo i figli a carico. Venire qui mi ha dato il coraggio e poi la possibilità di comprare la casa. Abbiamo comprato anche il box dove prima bruciavano le moto e poi li avevano chiusi.” Ecco il secondo simbolo nella narrazione: la casa nuova, i gabinetti ancora coperti di cellofan.
La casa è uno status e anche un principio di rivalsa e di libertà: “Non avevo padroni, ho fatto l’archetto in cucina, come abbiamo voluto”.
Anche io, l’ultimo dei generi, in quella casa ho trascorso le mie ultime 25 (forse più?) notti di Natale. Lì ho visto quello che da bambino avevo solo immaginato: il miracolo del Cep, Babbo Natale con il sacco dei regali. Prima arrivava per i miei nipoti, poi questi lo hanno portato per i miei figli, ora sono loro a manifestarlo per i bambini della cugina più grande.
Occorre chiedersi quanto del materiale raccolto in una intervista sia soggettivo o intersoggettivo, condiviso da persone diverse, generalizzabile. I riferimenti al marito (il nonno dei miei figli) evidenziano, per contrasto, alcune percezioni personali di mia suocera.
Il marito si inserisce meglio nel quartiere. Dotato di un carattere più leggero e ironico, meno pugnace, da uomo si concede di più l’uscita di casa. Incontra altri lavoratori e pensionati, ride, scherza, gioca alle carte nei box, vive il quartiere in modo diverso dalla moglie. Insieme vanno alle feste organizzate dalla società sportiva, di cui era presidente il figlio primogenito.
Al di là delle feste la situazione non era facile e quantomeno fastidiosa: “I ragazzi che si drogavano venivano a vomitare nelle cantine, a dormirci.” Anche le strutture parlano: la cantina di mia suocera che conserva qualche litro di olio e di conserva di pomodoro, ha tanti chiavistelli quanti, credo, la banca d’Italia, e forse non a torto perché l’abitudine a scendervi per qualche operazione di compravendita illecita non si è ancora persa.
“Dicevo a mio marito: andiamocene di qua, andiamocene di qua, ma lui ci stava bene. Aveva amici per il tempo ozioso, poi però correva dai nipotini. Io non sono mai andata in casa di nessuno, forse perché avevo mia sorella, che vuol dire tanto. Quando è mancata, una ragazza che conoscevo da bambina mi ha dato un biglietto con il suo telefono, mi ha detto: qualunque cosa io ci sono. Ecco non sono stata maltrattata dalla gente, sono io che non ho voluto…”.
Quel biglietto è ancora lì, appuntato sopra al telefono per essere utilizzato alla bisogna. Come quella notte che era saltata la luce, e subito erano arrivati a risolvere il problema.
Il comportamento del marito, pur legato alla tradizione e alla cultura del luogo di provenienza, pur legato alla famiglia, appare più adattivo, gli consente di incontrare meglio le persone del quartiere.
D’altra parte è nell’ampia famiglia, che si allarga via via con i matrimoni delle figlie e dei figli, che anch’esso ritrova ruolo e identità. Ed è probabilmente nell’alchimia dei diversi atteggiamenti verso il quartiere che la famiglia ha potuto far esprimere a tutti i suoi membri la propria personale resilienza, la possibilità di trovare un punto di equilibrio tra sé e il quartiere, in un luogo più o meno lontano o vicino, al Cep.
Nei percorsi migratori, e quasi tutte le vite lo sono, occorre essere un poco signori e un poco guerrieri, persino per mandare a scuola i figli. Mia suocera lo racconta così, con l’esempio della figlia più grande, che in realtà era piccolina di costituzione, ma a scuola andava bene e le piaceva studiare. A Genova arriva per fare la terza media, studia, ma alle interrogazioni piange mentre l’insegnante mormora tra i denti: “ecco vengono da giù, non sanno niente”. Al colloquio con i genitori, gli insegnanti le consigliano di rimandarla in seconda oppure di metterla in collegio. “A quella parola, mi sono girati i capelli in testa” dice la nonna mettendo le mani sul tavolo e bloccandoci tutti con la forchetta a mezz’aria. Perché la conosciamo e sappiamo che oltre l’educazione che riserva ai professori, la cosa non finirà lì, cercherà soddisfazione all’affronto, a questo come ad altri. Infatti si reca dal Preside, come dice lei “seria ma decisa” e, nel migliore italiano di cui dispone, gli spiega la situazione. Il Preside convoca immediatamente gli insegnanti: “Intanto questa ragazza è stata promossa in una scuola pubblica!” esclama, salendo di decibel “e voi se necessario le darete ancora più attenzione”. Una attenzione che si tradurrà in quattro materie da rimediare a settembre.
Parlare con i professori, dotati di autorità e potere sui nostri figli. Ci vuole coraggio, il coraggio di chi sa da dove viene, per incrociare la propria lingua con quella dell’autorità costituita.
La maestra elementare di un’altra delle tante sorelle, la sconsiglia di mandare la piccola al doposcuola, dove i ragazzini che lo frequentano non brillano per disciplina e linguaggio. La bambina non ha bisogno di aiuto a scuola, è sufficiente che a casa le si parli in italiano, per abituarla. Questo è il consiglio attento della maestra, in un periodo in cui al doposcuola i bambini di buona famiglia, in genere non ci andavano.
Nel rievocare, la donna pesa e confronta i consigli e gli affronti ricevuti, poi abbassando solo un poco la voce, in un respiro impercettibile, pensando a questo e ad altro ancora, con un eloquente movimento dei gomiti dice così: “Sono andata avanti sempre facendomi posto”. E tutti sentiamo la fatica, in quella fitta di doloroso orgoglio, che oggi a tavola coinvolge le tre generazioni presenti.
Allora le chiedo (ho una mia teoria) se le è costato rinunciare al suo dialetto per l’italiano.
“Non è stato un sacrificio” mi dice “rinunciare al dialetto con i figli mi ha arricchito e li ha aiutati”.
Accetto la risposta, le credo e non insisto; tuttavia conosco la voce di mia suocera quando torna al suo paese. Non è solo l’incremento del dialetto nel parlato, è il cambio di voce che colpisce.
Un’altra voce corrisponde a un’altra persona. Una persona che rimane nascosta, che è forse rimasta nascosta per anni e anni, nello stesso corpo, nella stessa mente. Come un abito rimasto sotto a un’altro. Due voci, due personalità, buone per due diverse culture, per contesti sociali diversi, per due diverse identità. Un’ipotesi, questa che faccio, che altri definirebbero come una torsione identitaria.
E’ il momento di chiudere il cerchio, lo faccio chiedendo dell’ultima casa. Quella di recente acquistata al paese, chiedo la ragione di quell’acquisto dopo tanti anni.
Ancora una volta devo imparare che le risposte a fatti recenti partono da lontano. In questo caso in un’eredità mancata, un intrigo di paese, come lo chiama la nonna, da cui nasce una voglia di riscatto. Ma non è solo questo. E’ soprattutto quel richiamo forte che sente suo marito. Quella radice che lo chiama e che gli fa misurare il calendario sulla posizione del Santo patrono del paese. Che ora è? E’ l’ora che il Santo è uscito, adesso attraversa la piazza, ornato di basilico; ora neonati nudi vengono alzati al suo passaggio. Suonano la banda e le campane, finché San Rocco trova, anche lui, una nuova casa. Nella chiesa di Matrice, sull’altro versante della collina su cui sorge Butera.
Una migrazione rituale quella del Santo, come gli uccelli che volano a cercare quel luogo caldo dove la storia ha inizio. Una nuova casa, lo stesso posto.
“Me la devo comprare una casa a Butera; me la devo comprare” ricorda le parole del marito e spiega: “Voleva anche dimostrare che era riuscito a essere se stesso. E così si è passato questo piacere e ci andava orgoglioso”.
Siamo arrivati alla fine, con queste parole da cui occorre ripartire per rileggere tutto, per riascoltare tutto. Cosa significa “essere se stessi”?
Chiedo: “E lei signora, come si sente quando è al suo paese?”. Risponde: “Mi sento me stessa…me stessa. Una persona che ti incontra ti riconosce, si ricorda di te, della tua famiglia, chi sei, da dove vieni. Conosco le pietre dove calpesto. Tornare al paese è ritornare ai tuoi ricordi, al castello dove andavo a ricamare, gli anni belli della giovinezza”.
Non c’è bisogno qui di referenze, di nascondere il numero dei figli, di fare domande anonime per il lavoro o per la casa. “Conosciuta da tutti e rispettata per quello che sei”.

Con queste parole si chiude la narrazione. Sono le parole che spiegano le altre, quelle sottese al discorso: appartenenza, identità, disagio. Disagio, che significa essere lontani da se stessi. In tanti anni di formazione nessuno me lo aveva mai spiegato in modo così preciso.
Capisco ora la stoltezza delle mie aspettative di parlare solo del Cep. Perché è chiaro che se questa è la storia di mia suocera, è certamente anche un pezzo della storia di questo quartiere popolare. Cosa imparo da tutto ciò? Che il Cep (come forse tutto quanto) è un racconto, una matassa di narrazioni il cui inizio è in altri tempi e in molti altri luoghi. Non lo si può comprendere guardando solo a quelle colline piene di cemento, così come non si conosce un uomo se non condividendone il percorso. Il Cep, Voltri, Pra, non sono che l’insieme delle storie di chi vi ha vissuto e vivendoci li ha immaginati, costruiti e ricostruiti nelle proprie rappresentazioni.
Dunque, per essere precisi, questa è la mia narrazione (di cui assumo la responsabilità) dell’intervista alla nonna dei miei figli. Un racconto che conserva per lo più uno sguardo storico, volto all’indietro, anche se non troppo, ma quel tanto che basta a lasciare il bisogno di uno sguardo sull’attualità di questo quartiere.
Mi chiede mia moglie, di cosa ho raccontato in queste pagine. Della nonna? Della famiglia? Del quartiere? Io credo, di tutto questo, ma soprattutto di appartenenza e identità. Argomenti buoni per ciascuno e allora, sia pure con un po’ di sorpresa, bisogna ammettere che il Cep parla anche di noi.
BUONGIORNO, CEP
di Giampiero Rappa (attore e regista teatrale)
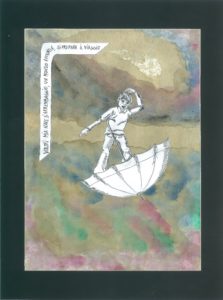
CEP: Autunno 1978. Insieme ai miei genitori ed ai miei tre fratelli scendiamo all’ultima fermata dall’autobus 199 per recarci nella nostra nuova casa. Insieme a noi ci sono circa un centinaio di persone. Ho cinque anni, ma non sono l’ultimo della famiglia. Mio fratello più piccolo ha poco meno di sei mesi. Mia madre lo tiene stretto a sè, c’è freddo ed un vento che ci porta via; proprio per questo si cammina tutti a passo spedito con l’emozione di mettere piede, finalmente, nel tepore della dimora tanto attesa.
Arrivati davanti alla porta di casa mi inginocchio e bacio per terra come fa un Papa che benedice il suolo straniero. Mio fratello maggiore suona il campanello pur sapendo che non potrà rispondere nessuno ma questo gesto corrisponde al suo modo di festeggiare ed al suo bisogno di sapere che sarà accolto. Dopo il suono però, salta la luce in tutto il condominio e ci troviamo subito al buio, noi come altre nove famiglie. Mio padre non ci pensa un attimo e molla subito una sberla a mio fratello come se la colpa dell’ impianto elettrico difettoso fosse sua. Il ceffone, nonostante la scarsa visibilità, centra in pieno la guancia ma non fa tornare la luce, ovviamente. Alla fine si entra lentamente, come fossimo dei ladri, si poggiano le valigie e si va subito a dormire. Il giorno dopo sarà una meravigliosa luce proveniente dalle persiane a svegliarci. Un splendida giornata primaverile.
Buongiorno Cep, luogo che imparerò ad odiare e ad amare.
Imparerò ad amarlo per le colline, per la vista del mare, per i colori e i profumi che preannunciano l’inizio delle nuove stagioni. Per gli amici, per quelle poche occasioni di aggregazione come la festa dell’Unità nella piazza della biblioteca. Una piccola piazza che diventava immensa quando era piena di gente. E come poter dimenticare le feste del 25 Aprile e del Primo Maggio al pratone? Sono durate pochi anni, quelle feste. Era già il segnale che sarebbe finito, a breve, il Pci.
Ho amato la biblioteca(che resiste ancora solo grazie al volontariato). Un rifugio per molti ragazzi dove si poteva leggere un libro, un giornale, incontrare qualcuno e, perché no, la donna della tua vita come è successo ad un mio caro amico.
Ho amato la parrocchia e gli amici del gruppo del coro. Ho amato in particolare la chiesa succursale del Cep alto, una struttura che, se non sbaglio, prima era un garage.
Ho amato fare qualche edizione della Via Crucis nel ruolo di Ponzio Pilato. Una volta,mentre nella piazza grande chiedevo al popolo se liberare Gesù o Barabba, qualcuno per farmi ridere mi urlò fortissimo dalla finestra di un palazzo “Rappa al telefono!”
Ho amato la scuola elementare, il maestro e le maestre.
Ho amato il partigiano un pò bassino che, con una voce vibrante, ogni 25 aprile ci raccontava la sua storia di combattente sulle alture al confine tra la Liguria e il Piemonte. Verso la fine del suo monologo piangeva regolarmente, sempre nello stesso punto del discorso.
Non ho amato l’isolamento del quartiere, le case orribili, le pietre lanciate contro gli autobus nei primi anni ottanta, l’ignoranza e la cattiveria di alcune persone.
Gennaio 19 97. Parto per Roma. C’è una nuova farmacia nel quartiere gestita da un signore brianzolo di nome Carlo e da sua moglie Susanna. Quando esci da quella farmacia stai meglio anche se non hai comprato medicine, eppure non spacciano nulla di strano, come invece avviene in qualche zona del quartiere. Sono il loro sorriso e la loro accoglienza a farti stare bene. E di lì a poco sarà proprio l’entusiasmo di Carlo ed alcuni suoi collaboratori a dar vita all’area Pianacci. Finalmente nel quartiere si sente della musica, ci sono spettacoli, si organizzano tornei di calcetto e pallavolo, c’è internet per tutti , un centro per aiutare chi è senza lavoro e tante altre iniziative. Insieme a tutto questo arriva la speranza di sconfiggere quel vuoto che anni prima aveva contribuito a distruggere molte vite. Ma a qualcuno questo non piace. I cambiamenti, anche belli, a volte spaventano. Così, per una questione di decibel, Carlo si becca una denuncia e si torna tutti a dormire,sereni e annoiati come prima. Eh già, meglio il silenzio assordante che un bella musica capace di aggregare!
97. Parto per Roma. C’è una nuova farmacia nel quartiere gestita da un signore brianzolo di nome Carlo e da sua moglie Susanna. Quando esci da quella farmacia stai meglio anche se non hai comprato medicine, eppure non spacciano nulla di strano, come invece avviene in qualche zona del quartiere. Sono il loro sorriso e la loro accoglienza a farti stare bene. E di lì a poco sarà proprio l’entusiasmo di Carlo ed alcuni suoi collaboratori a dar vita all’area Pianacci. Finalmente nel quartiere si sente della musica, ci sono spettacoli, si organizzano tornei di calcetto e pallavolo, c’è internet per tutti , un centro per aiutare chi è senza lavoro e tante altre iniziative. Insieme a tutto questo arriva la speranza di sconfiggere quel vuoto che anni prima aveva contribuito a distruggere molte vite. Ma a qualcuno questo non piace. I cambiamenti, anche belli, a volte spaventano. Così, per una questione di decibel, Carlo si becca una denuncia e si torna tutti a dormire,sereni e annoiati come prima. Eh già, meglio il silenzio assordante che un bella musica capace di aggregare!
Nonostante questo episodio e altri più gravi avvenuti nel passato, non ho mai provato vergogna per il mio quartiere e, anzi, quando giro l’Italia per lavoro e capito in periferie popolari come il Cep, mi sento a casa e ci passeggio volentieri, come se fossi in via della Benedicta o in via Martiri del Turchino. Camminando penso che non potrei mai rinnegare le mie radici, anzi mi chiedo cosa avrei potuto fare di più per migliorare il mio quartiere.
IL MIO CEP
di Cosimo Damiano Motta (fotopoeta)

Il “mio” Cep, o meglio il Cep per me, è una storia strana o una storia al contrario.
Parlerò, dunque, di quel Cep, cioè quello che ho visto quando ero adolescente, quello che mi faceva paura solo a nominarlo, quello che quando poi l’ho conosciuto non mi ha più fatto paura.
Erano gli anni in cui la “guerra” era al culmine ed il “clima” incandescente.
“Guerra” e “clima”, ovviamente, sono eufemismi per descrivere cosa succedeva in quegli anni.
Pensandoci bene, però, solo il “clima” è un eufemismo, in quanto non mi riferisco a quello meteorologico, ma alle tensioni che si percepivano anzi si vedevano. Invece, in quanto la “guerra”, quella c’è stata e come, con bastoni, spranghe, catene, e gli immancabili remi delle barche.
Gli abitanti di Voltri, fino a quel momento avevano vissuto entro
Andiamo con ordine: correvano gli anni ’70; Voltri, che fino a quel momento era (o credeva di essere) un tranquillo borgo marinaro ligure ha visto “cadere” nel giro di poco tempo il suo confine che volgeva sulle immediate alture di Pra, ove si erano insediati “i terroni o caccari”, nuovi “barbari” venuti, però, questa volta dal sud.
In questo racconto li chiameremo “caccari”, perché è più dispregiativo, e perché la definizione di allora voleva essere tale.
La popolazione “caccara” non aveva radici precise ma molte radici, e questo, secondo i voltresi, li rendeva più pericolosi.
In realtà il vero problema che attanagliava i “voltresi” era il fatto che “i caccari”, ancorché già presenti da molti anni a Genova, si erano improvvisamente raggruppati sul confine est-nord di “Utri”, dando origine ad un nuovo villaggio che veniva chiamato Cep (acronimo ufficiale di Centro Edilizia Popolare, ma che ha avuto anche altre traduzioni e declinazioni) .
Questo raggruppamento “caccaronico” ed eterogeneo aveva generato la paura, e la paura da sempre genera, come ha generato anche allora, mille tensioni fino alla “guerra” delle spranghe. Guerra che ha segnato l’inizio della pace che si è però realizzata concretamente circa 15 anni dopo, quando il Cep, per paradosso, si era addirittura ampliato verso est, fin sopra Pra, arrivando a lambire i territori di Pegli.
Per la verità quella “guerra” aveva segnato anche le nostre menti (di adolescenti di allora) ed ancora echeggia in qualche ricordo.
Dicevo prima che la mia è una storia al contrario, nel senso che in realtà ero (sono) un “caccaro” ma abitavo-stavo da questa parte, cioè a Voltri.
I voltresi, che mi hanno visto da piccolo, non mi hanno mai considerato un vero “caccaro” o un intruso nonostante le mie origini fossero chiare e dichiarate. Credo ciò sia dipeso sostanzialmente dal fatto che mio padre lavorava in ferrovia ed aveva un ufficio nella stazione di Voltri. Aveva un ufficio, dunque, nel suo piccolo, era importante! Da lui dipendeva la manutenzione dei binari, dunque la circolazione dei treni del tratto Arenzano – Pegli. Con lui, (ed in diversi casi addirittura alle sue dipendenze) lavoravano persone i cui cognomi spaziavano dall’italianissimo Sig. Rossi, ai genovesissimi Camoirano, Bruzzone, Somaglia ed altri. Questo fatto, unitamente al non trascurabile numero di fratelli (ben 6+1 cioè una sorella) mi aveva (ci aveva) consegnato il passaporto voltrese ad “honorem”. Mia madre, poi, era una donna buona, conosciuta da tutti per la sua straordinaria e totale dedizione alla numerosissima famiglia, al punto di non avere il tempo nemmeno per andare a messa.
A questo sopperivo io, che a nome di tutta la famiglia, frequentavo la parrocchia di Sant’Ambrogio, le Suore di Via Buffa, il bar dell’Acli – sempre di Via Buffa – ed il cinema Ambrosiano – ancora di Via Buffa. Quanta roba c’era in Via Buffa!
Intanto, quel Cep di fine anni ’70, primissimi anni ’80, era basso, cioè in sostanza si dipanava lungo quel breve arco che “sorvolava” appena la Via Romana di Pra, da Via Ventimiglia alle sorgenti sulfuree; una linea di case lungo l’autostrada. Sopra era tutto un divenire che poi è venuto, a suon di cementificazione, distruggendo tutto quello che c’era da distruggere; sentieri e falde in primis.
Un giorno, forse dell’estate del 1978, al termine della messa vespertina, don Renzo, Vice Parroco di Voltri, mi disse: vieni con me, accompagnami al Cep.
Il mondo mi si è fermato davanti, il sudore caldo dell’estate è diventato freddo, il respiro affaticato e la saliva si asciugò.
Al Cep? A fare cosa?
A parlare con Padre Sergio.
E chi è Padre Sergio?
E’ il vice Parroco del Cep.
Fine del dialogo (evidentemente i vice parroci erano ambasciatori di pace!).
Uscimmo dalla parrocchia e salimmo a bordo della 127 verde, parcheggiata sul marciapiede, davanti a Pina la fioraia, e via, verso il ponte, svolta a destra su via Lemerle, poi via Buffa, e fin qui tutto bene, ero a casa. Una volta imboccata via Ventimiglia, avvertivo la paura della frontiera, che per me era rappresentata dalla “Standa”; oltre non ero mai stato, non avevo mai osato, era estero.
Via Cravasco mi si presentò dopo una curva a 360°; un palazzone alto, ed a seguire case un po’ più normali, perfino belle, con aiuole a alberelli.
Meno peggio di quello che credevo; cioè quello che credevo non sapevo veramente cosa fosse, e non lo so neppure ora. Era sicuramente un luogo comune: il Cep era cattivo, al Cep c’erano i cattivi. Chi fossero, dove fossero, che faccia avessero non lo sapevo e non lo so o comunque non ne ho mai conosciuti di cattivi propriamente detti.
Diciamo che nella mia mente echeggiavano i racconti della “guerra” fra voltresi (che si definivano pescatori, anche quelli che non lo erano) e “caccari”.
Pescatori era “chic”, mentre “caccari” era dispregiativo. Chi avesse stabilito questa specie di scala sociale non si sa, o meglio lo avevano stabilito i voltresi perché si sentivano invasi.
Avevo il cuore in gola e mi tremavo le gambe; ma Via Cravasco è breve, dunque dopo un minuto l’avevamo percorsa tutta, fino a giungere all’altro capo, che era quasi Palmaro (figo!) e si vedevano le fasce coltivate dai contadini liguri e i palazzi nuovi sull’altro fronte, che era di nuovo Genova. Insomma quel Cep era una sorta di striscia di Gaza, intensa ma breve.
Lì ci siamo fermati ed abbiamo atteso che arrivasse Padre Sergio. Don Renzo è sceso dall’automobile, sicuro, tranquillo (ma lui era alto, giovane, bello e vestito da prete, e si sa, i preti sui “caccari” fanno sempre effetto!) io sono rimasto dentro (in verità avevo paura). Comunque da quella posizione osservavo e prendevo confidenza visiva con quel mondo, (per me più che nuovo, di ritorno).
Dopo circa 10 minuti arrivò, a bordo di una A112 blu, un giovane baldanzoso e belloccio. Renzo gli andò incontro, i due si salutarono calorosamente ed iniziarono a parlare. Io, da dentro l’automobile li guardavo e vidi che dopo poco si diressero verso una palazzina con i portici. Restai in auto per circa mezz’ora, solo al mondo, poi vidi tornare Don Renzo insieme al giovane di prima che si avvicinavano. Mi feci coraggio e scesi; Renzo mi presentò Padre Sergio.
In verità io attendevo uno vestito da prete o da frate, invece costui era vestito, come si dice, in borghese, jeans e maglietta blu e parlava romanesco, cosa che me lo rese subito simpatico.
Anche la chiesa mi sorprese, perché era nei fondi del palazzo. A Voltri, nei fondi dei palazzi c’erano le cantine, i negozi o i garages; al Cep le chiese.
Non so se i “ceppisti” erano veramente cattivi, ma di sicuro erano (per me ragazzo di allora) strani; avevano un prete in borghese ed una chiesa nei fondi di un palazzo, e pure senza campanile (forse erano avanti?)
Arrivarono due ragazze, e Padre Sergio ci presentò. Una si chiamava Nunzia, un’altra, più giovane, Elvira.
Per farla breve, la domenica successiva, (sicuramente attratto dalle ragazze) presi il coraggio a quattro mani ed andai a messa al Cep.
Ammetto che attraversare Via Cravasco, da solo, non fu propriamente come fare una passeggiata in via Buffa o andare in auto con don Renzo. Senza guardarmi attorno, senza guardare le persone, a passo svelto giunsi alla casa dove c’era la chiesa.
Non conoscevo nessuno ma riconoscevo molti “me”, capivo molti dialetti. Mi aspettavo di vedere i “cattivi” invece vedevo tante mie mamme, nonne e nonni e zii e cugini, che, con il vestito della festa, giungevano per ascoltare la messa. Arrivò anche Padre Sergio; gli andai incontro per farmi riconoscere, ma non ce ne fu bisogno, perché mi chiamò subito per nome. Fu il primo, a Genova, che iniziò a chiamarmi con il mio secondo nome.
Dopo la messa, conobbi Padre Balbi, il parroco titolare (e genovese), anche lui in borghese ma con pantaloni più in stile, camicia nera e crocetta sul petto.

Scoprii un mondo fatto di tanti paesi diversi, mescolati fra loro; forse quella diversità che faceva paura ai voltresi di allora perché in realtà era unione, forza, solidarietà. Erano tutti “paisà o cumbà”, e questo era ciò che veramente spaventava.
In me invece svanì la paura, ormai ero del Cep, o anche del Cep.
Conobbi Ezio Arata, attivissimo in tutte le attività della parrocchia, una sorta di coordinatore instancabile dei ragazzi. Secondo il precetto voltrese avrei dovuto avere paura di lui. Ma si poteva avere paura di uno che oltre ad essere attivissimo in parrocchia, faceva l’infermiere radiologo all’ospedale San Carlo di Voltri e faceva i raggi a tutti i voltresi che si rompevano qualcosa, o avevano qualche problema diagnosticabile con quella tecnica? Mio padre si ammalò ed Ezio “lo curò”, lo accudi; come potevo aver paura di lui e dei suoi amici. Lui per me era il vero passaporto per il Cep.
Nunzia ed Elvira erano figlie di impiegati statali e carabineri; altri erano figli di impiegati vari, operai, tutti studiavano. Cominciava a crollare in me, anzi crollò, tutta quella mitologia “voltrica” per cui abitare al Cep, era unicamente sinonimo di poco di buono; non era vero.
La verità, l’ho capito dopo, da grande, stava invece nella “chiusura” mentale, seppur giustificata e giustificabile, che regnava di qua del confine della “standa” di Via Ventimiglia, cioè quella cosa che viene chiamata impropriamente paura del diverso, laddove diverso è chiunque arrivi da lontano; se poi questo “parla strano” e si associa ad altri venuti prima di lui per il solo fatto che solidarizza, trova casa, amici ecc., allora la paura fa nascere il pregiudizio.
Questo è quello che è successo, negli anni ’70/’80 fra Voltri ed il Cep, (il primo Cep).
Poi, come fortunatamente succede sempre (ed è successo) le cose cambiarono, perché i figli dei “ceppisti” frequentarono le scuole dei voltresi, le parrocchie, i campi da calcio, la piscina, la palestra; si fidanzarono e si sposarono. (Qui mi si consenta di elogiare i padri costituenti e la Costituzione; quella che oggi qualcuno, giovane e frettoloso, vuole stravolgere, o addirittura strappare!!! Mi auguro che non gli verrà consentito).
Intanto il Cep fisico, materiale, crebbe; nuovi palazzoni furono costruiti (a danno delle fasce dei contadini) ed in quei palazzoni andarono ad abitare anche i genovesi. Il Cep subì l’invasione contraria, “s’imbastardì” con l’innesto di abitanti indigeni e non fu più nemico.
A questo si aggiunga che parallelamente, crebbe anche Voltri, quella fisica e materiale, oltre che culturale, che da borgo di mare divenne altro, forse periferia, tutto a danno delle colline immediate e coltivate. Per orgoglio, questo nuovo quartiere, si chiamò “Voltri2”; una sorta di giustificazione per avere agito da coccodrilli, divorando i “loro colletti” che tanto amavano, ma che di fatto era quasi un Cep o un contro Cep, dove giunse ad abitare anche altra gente, estranea alla logica voltrese, ma ormai il “muro” era caduto, e non ci fu un’altra guerra, fortunatamente.
Voltri, Voltri2 ed il Cep iniziarono a condividere le strade, gli autobus, i servizi, i supermercati.
Il pregiudizio, che è sempre duro da sconfiggere, ha cambiato obiettivo, è riuscito (come sempre succede) ad individuare un nuovo nemico, chiamato “extracomunotario-clandestino” ed è riuscito anche nell’intento di accomunare ed unire i nemici di un tempo contro il nuovo “invasore”.
La storia dell’uomo continua, sbaglio dopo sbaglio, prima o poi riusciremo anche a dare risposta alla famosa domanda: “io chiedo, quando sarà, che l’uomo potrà imparare“? (F.G.).
CENTRO ELEMENTI PERICOLOSI
di Gianni Priano (poeta)
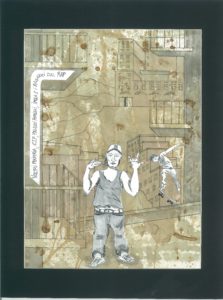
Quando arrivarono i meridionali i voltresi li presero in antipatia perché voltresi sì ma non stupidi e , dunque , capirono subito che quelli – i càccari – erano bravi nell’amore . Più bravi di loro.
Pareva vivessero per fottere . Scrutavano , annusavano , penetravano . In strada i loro sguardi scuri e umidi misuravano un mondo unidimensionale la cui cifra , sostanza , essenza , prospettiva e teleologia portava il nome di sticchio . O di pacchio .
Più vari – e distraenti – erano invece gli interessi dei nordici voltresi . Non che la mussa non riscontrasse presso di loro un discreto credito , tutt’ altro . Però le toccava coabitare , alla poveretta , con altre forti passioni e abitudini . La Sampdoria , per esempio ( o il Genoa ) . E il Partito ( Comunista ). E le palanche . Ergo : dispersione di energie . Forze strappate alla Camera da Letto .
Le donne voltresi , in buona percentuale , erano attratte dai gabibbi . Quello che non facevano lo immaginavano e quello che non immaginavano lo temevano . E nella scodella di quelle oscure pudicizie al terrone piaceva pucciare il naso . Per poi dire , di ogni donna conquistata , “punita “ oppure “ ci ho fatto il dispetto “.
I rapporti tra Voltri e la Bassa Italia assunsero nuovi e più aspri contorni quando , alla fine degli anni Sessanta , sorse sulle sovrastanti colline , un tempo dedicate alla colture del baxeicò , il quartiere del Cep . Che cos’ era il Cep ? Intanto Cep significava e significa Centro edilizia popolare ( Centro elementi pericolosi si parafrasò immediatamente ).
I miei ricordi hanno a che fare con una manciata di, poco ecumenici , episodi . Per esempio con l’assalto cepparo a Forte Ontario ( “ dell’ Ontario lupi siam” ) che vide me ed i miei compagni di Via Alassio , Via Laigueglia e Via Buffa ( “le strade nuove” ) attaccati e , se la memoria non mi inganna , sconfitti da una banda àscara. Ho in mente un fuggi fuggi generale e , nello stesso tempo , il valore sul campo di battaglia di Binda altrimenti detto Ardito .
Era gente nata con il labbro già rotto ed il naso sbucciato quella venuta dalle Calabrie , fumatori a otto anni e formidabili tiratori di pugni e sputi . Insomma , tolto il Binda (Ardito ) , noi ce la facemmo , senza meno , sotto . E Forte Ontario , in Via Colletti di Voltri , fu espugnato ( a raderlo definitivamente al suolo e disintegrarne muri , pavimenti , soffitti , glorie ed infamie non furono però i saraceni ma le ruspe della Società Autostrade perché l’avamposto , ex palazzina sul confine città – campagna , dovette cedere il passo alla A26 ) .
Fece seguito la vicenda per nulla edificante che ebbe come attori cepponi più grandicelli ( quindici anni ? venti ? )e pescatori locali i quali , ad opera dei mandarini, si ritrovarono – se non sbaglio – uno o più gozzi danneggiati . Partì , così , una sorta di spedizione punitiva : una sera pescatori , operai , portuali , bottegai , dottori si misero in marcia armati di bastoni . Non era propriamente una rappresentazione accostabil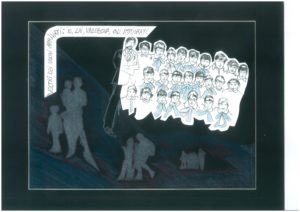 e al celebre “ Quarto Stato” di Pelizza da Volpedo anche se , per certo , la maggioranza degli arrabbiati nostrani era composta da comunisti e socialisti . Come si risolse la tenzone , se militarmente o diplomaticamente , non so.
e al celebre “ Quarto Stato” di Pelizza da Volpedo anche se , per certo , la maggioranza degli arrabbiati nostrani era composta da comunisti e socialisti . Come si risolse la tenzone , se militarmente o diplomaticamente , non so.
Ci fu poi la questione di Lorenzo ( ma siamo oramai all’alba degli anni Ottanta ) messo spalle contro il muro e derubato della giacca di renna . Negli ultimi anni Settanta , per un decennio molto abbondante , il Cep era divenuto terreno di conquista del mercato dell’eroina che aveva operato una radicale trasformazione su questi immigrati fino a quel momento bulli , sciupa femmine , occupatori abusivi di case , spernacchiatori di polizia e carabinieri e vittime della malagiustizia : ora non c’era più , sulle colline di Voltri , la cavalleria rusticana di importazione , i Bellantoni più o meno di serie B o C, ma gli spacciatori metropolitani , i tossici suburbani .
Questo era il Cep dei miei vent’anni .
E ora ? Ora sono andato a vedere. Ho fotografato , scrutato . Annusato l’aria . Devo ritornare e poi ritornare ancora . E ancora . E ancora. Forse , a quel punto , se avrò qualcosa da raccontare , racconterò.
APPUNTI PER UN PRESEPE ESTIVO CON GIOCATORI DI CARTE ( LO SMILZO E IL GROSSO), FIORI FINTI E VERI, VERSI NERUDIANI, RAGAZZA CON CESTO DEL PANE E UNO CHE SI AFFANNA A METTERE IN MOTO UNA MALEDETTA VESPA CHE, PERO’, NON PARTE. di Gianni Priano (poeta)
Elias Canetti suggeriva di non andare sempre fino in fondo poichè vi sono tante cose in mezzo ed è su queste cose che, in una mattina di luglio, ho puntato lo sguardo entrando al Cep “basso”, quello di Via Cravasco, delimitato, nella direzione del mare, dai resti asfaltati e dissestati di un’ antica “creuza” e della collimante autostrada.
“basso”, quello di Via Cravasco, delimitato, nella direzione del mare, dai resti asfaltati e dissestati di un’ antica “creuza” e della collimante autostrada.
Arrivo e guardo. Senza la pretesa di “vedere”. Guardo e prendo nota. So che a forza di guardare può capitare di intravvedere e, quindi, di approssimarsi ad una qualche verità, come chi bivacca nel punto in cui il sentiero si interrompe ed apre ad una radura, sulla mezza costa di un monte. Guardo, allora, il signore un poco oltre i sessanta( cappellino con visiera, pantaloncini e camicia di jeans) che spazza il marciapiede. Segno sul taccuino i cognomi sul citofono del primo palazzo che incontro: LIMARDO, OTTONELLO, SERIO, MOUDNIB ABDELILLAH, PRENCIPE, CORONA, SCARPETTA: soltanto il primo risulta spiccatamente “nostrano”. Gli altri parlano di Calabria, Puglia, Marocco, Sardegna.
Il buongiorno me lo da una ragazza uscita dal forno con la cesta del pane, si porta addosso l’odore di farina e bottega che ho nel sangue, insieme a quello di terra e bosco. Sfodera un sorriso imperdibile mentre mi saluta: sembra la statuetta meccanica di un presepe(quella che, nel mettere allegria, scuote la polvere che stagna nell’aria). Il presepe è un presepe ceppista. Del quale fa parte anche il piccolo bar con il suo piccolo bagno (che visito subito) lindo, fiorito di fiori finti, ghirlande colorate, una confezione di disincrostante- igienizzante, sapone liquido ai frutti di bosco, medaglione variopinto al muro: nel cerchio un uomo guida un carretto trainato da un asino o da un cavallo. Forse è un souvenir, un segno- comunque- della fatica. E un idillio del lavoro.
Il bar è, come si dice, “decoroso”, appese vi sono foto di cinema e teatro( il genovesissimo Gilberto Govi, Totò, Chaplin, la Monroe). Una targa recita Neruda. Il barista è un quarantenne molto tatuato e molto palestrato. La radio- a stecca- suona canzoni italiane, Il Secolo XIX figura in bella mostra, spalancato su un tavolino. Su un pilastro campeggia la foto di un ragazzo rapato a zero: un serpente gli si arrampica sulla spalla e fa capolino sul palmo della mano.
Il signore che spazzava il marciapiede ora gioca a carte sotto il porticato di cemento armato che è luogo di passaggio ma anche prolungamento dell’esercizio. I due giocatori sono “lo smilzo” e “il grosso”. Li osserva un giovane uomo bruno e scuro di pelle che potrebbe provenire dal Sudamerica. Oltre il portico l’aiuola( forse ulteriore privata espansione del bar) splende di gerani, rose, piante da vaso. Accanto all’aiuola vi è una casetta di legno che parrebbe destinata ai bambini( o agli attrezzi del barista-giardiniere?) e accanto, ancora, uno spazio, questo sì, certamente per i bambini, dotato di scivolo.
Pago il cappuccino e la brioche( piuttosto cattivi) due euro e venti e vado, mentre uno si sta affannando a mettere in moto una maledetta vespa che , però,non parte.
